 La rinuncia di Bartleby.
La rinuncia di Bartleby.
Bartleby & Moby Dick
La tentazione di un paragone fra i due testi, sulle orme di Borges, è irresistibile.
Ad una prima analisi emerge ovviamente una serie di contrapposizioni binarie: da una parte la narrazione abnorme, mostruosa, senza limiti di Moby Dick, che fagocita nella forma romanzesca l’epos e la tragedia; dall’altra la misurata eleganza quasi minimalista di Bartleby. L’avventura marinara che si dipana negli oceani del mondo è agli antipodi di una vicenda urbana che a ben vedere ha solo due locations e in cui accade poco più di nulla.
Emergono però numerosi parallellismi, precisi e sconcertanti.
Ahab e Bartleby vanno entrambi incontro alla morte, a causa della propria ostinazione. Sebbene Ahab sia ossessionato, e Bartleby piuttosto rassegnato. Entrambi agiscono contro ogni logica e ogni senso comune, contro gli espliciti appelli di conoscenti e colleghi. Siamo forse di fronte a due forme estreme di individualismo? Di certo i due personaggi sono dei solitari: Borges lo considera “il tema costante di Melville; la solitudine fu forse l’avvenimento centrale della sua sventurata vita”.
La loro entrata in scena inoltre è ritardata (un quinto della narrazione già alle spalle) & sapientemente preparata da quanto viene anticipato sul loro conto.
Perché l’opposizione binaria Ahab/Bartleby si sdoppia, e in entrambi i casi la vicenda viene esposta in prima persona da un narratore interno. La tecnica narrativa viene qui riproposta, ed a prendere il posto di Ishmael è in questo caso l’ultimo datore di lavoro di Bartleby, l’anonimo avvocato che non rivela mai il proprio nome (nessun “Call me Ishmael” qui). Sia l’uno che l’altro sono testimoni, inizialmente partecipi ma infine impotenti, della risolutezza con cui Ahab e Bartleby procedono verso l’autodistruzione.
Queste due coppie sono affiancate da altri personaggi, il cui numero è naturalmente notevole nel caso del romanzo e limitato nel racconto. Turkey, Nippers, Ginger Nut (non mi riesce di usare i nomi italianizzati) e gli altri personaggi sono i comprimari: persone per la maggior parte mediocri, insignificanti, magari sgradevoli; incapaci anche solo di immaginare la vita interiore di Bartleby, individuo probabilmente altrettanto anonimo se non per il suo comportamento―cioè per la sua caparbietà intellettuale.
La scelta di Bartleby
Dopo aver raccontato della morte di Bartleby, misera eppure a suo modo dignitosa, il narratore svela l’unico retroscena che è riuscito a scoprire sulla vita precedente del proprio ex-stipendiato; e si tratta solo di una voce di incerta veridicità. Ma questa rivelazione crea una risonanza con quanto ci era già stato narrato, che a mio parere è la vera chiave di lettura (se non altro di questa mia lettura) del testo. Bartleby lo scrivano, che per lavoro copiava aridi documenti notarili, era precedentemente impiegato all’ufficio delle missive smarrite a Washington; in quel caso il suo compito era bruciare le lettere che non erano mai giunte a destinazione; lettere spesso importanti ma ormai inutili.
C’è quindi una chiara contrapposizione tra (ri)produzione ed eliminazione.
E trovo curioso che l’escamotage narrativo di Melville inverta la corretta sequenza cronologica; poiché la verità, apparentemente, è che Bartleby abbia dibattuto per qualche tempo con se stesso le conseguenze emotive del suo impiego alle Poste, quell’umanità perduta e data alle fiamme quotidianamente; abbia cioè tentato di opporsi agli effetti della distruzione (e in questo senso il suo grigio lavoro di copista acquista una forte simbologia); ma che sia stato incapace di contrapporsi, e che alla fine l’istinto di morte abbia avuto la meglio.
Bartleby rinuncia; diminuendo progressivamente la propria vita; fino alla sottrazione finale. Non a caso uno dei suo primi dinieghi riguarda la decisione, dapprima temporanea e poi definitiva, di non copiare (ri-produrre) più. Nelle lunghe ore di riflessione, trascorse ad una finestra che dà su un muro, Bartleby chiaramente non guarda fuori ma dentro di sé. Non trovandovi le ragioni, o forse la forza, di continuare a vivere. Scegliendo di rinunciare.
La scelta di Bartleby non riguarda una qualche forma di opposizione all’ordine costituito, e/o di disobbedienza. È una ricerca più profonda, intima. Che lui porta avanti caparbiamente, coerentemente, fino alle ultime conseguenze.
Questa interpretazione non è forse giustificata dal testo, o magari meno di altre; forse è già stata espressa, meglio di come l’abbia fatto io. Di certo ha un profondo significato per me; e sono felice di aver riletto il racconto in un determinato periodo della mia vita. Porterò Bartleby con me a lungo, forse per sempre.
La solitudine di Bartleby
Come dicevo all’inizio citando Borges, la solitudine è senza dubbio uno dei temi principali del racconto. Che ruolo ha nella scelta del protagonista? Ha scelto la solitudine?
Magari il mio è un caso di wishful thinking, ma la mia convinzione è che Melville volesse implicare che se Bartleby non fosse stato solo, così radicalmente solo, non avrebbe preso quell’ultima decisione; forse nemmeno le precedenti. Eppure Bartleby è un simbolo di estrema sincerità intellettuale, nei confronti di se stesso prima che degli altri; mi sembra anzi che ogni rapporto sociale sia per lui secondario, subordinato (e quindi, eventualmente, prescindibile) alla propria vita interiore.
Eppure la sua non è forse una forma di empatia molto profonda, nei confronti di persone che con tutta probabilità non ha mai nemmeno conosciuto?
Lo scrivano
Perché dunque ambientare una parabola così universale in un contesto tanto specifico? Forse, riprendendo quanto dicevo all’inizio, Melville cercava un contrappunto alle narrazioni marinare, che avevano occupato metà della sua pur breve carriera di romanziere. Io credo però che davvero cercasse temi genuinamente nuovi nell’ambito della letteratura: come recita l’incipit del racconto, “an interesting and somewhat singular set of men, of whom as yet nothing that I know of has ever been written:—I mean the law-copyists or scriveners”.
Del perché questa recensione contiene spoilers
Sto iniziando a convincermi che la trama abbia un ruolo secondario, subordinato (e quindi prescindibile) nella narrativa melvilliana. Pensateci, quanti conoscono l’epilogo di Moby Dick, pur non avendolo letto? Eppure questo non danneggia il valore, o anche solo il piacere, della lettura. Per non parlare del fatto che, spesso, si tratta di trame esili.
La biblioteca di Babele, Edizione Franco Maria Ricci
Alcuni anni fa, occupandomi di Gianni Celati scoprii che aveva lavorato anche come traduttore, tra le altre cose proprio di Bartleby the Scrivener. Incuriosito cercai il testo nelle biblioteche universitarie, imbattendomi invece in un’edizione brossurata della Biblioteca di Babele, la collana di testi curata da Jorge Luis Borges. In occasione di un gruppo di lettura di Moby Dick ho deciso di riprendere in mano il testo, scoprendo che la mia biblioteca cittadina ha in catalogo una splendida edizione limitata, sempre della Biblioteca di Babele: cartonata, stampata su carta a mano con filigrana, tipograficamente ricercata, arricchita da un disegno di Tullio Pericoli in copertina. Non voglio sapere quanto possa costare un gioiellino del genere, talmente chic che il prezzo nemmeno è riportato e talmente esclusivo che il titolo dell’opera non compare sulla copertina.
La traduzione è quella di Enzo Giachino.
Mi rimane la curiosità di leggere la versione di Celati.
Herman Melville
Bartleby lo scrivano (1853)
traduzione di Enzo Giachino, prefazione di Jorge Luis Borges
pp. 80
F.M. Ricci, 1992
Giudizio: 5/5.
 “Edwin Boomer conduceva la vita più letteraria che si possa concepire”.
“Edwin Boomer conduceva la vita più letteraria che si possa concepire”. “Una riga per l’ambiente, una per la cronaca più o meno nera, una per l’epilogo a sorpresa”.
“Una riga per l’ambiente, una per la cronaca più o meno nera, una per l’epilogo a sorpresa”. Un libro delizioso, sorretto da una prosa originale & seducente. Ho l’impressione che se dovessi scrivere un libro sarebbe molto simile a questo, per spirito, tono, uso delle fonti. Ma questo non interessa a nessuno.
Un libro delizioso, sorretto da una prosa originale & seducente. Ho l’impressione che se dovessi scrivere un libro sarebbe molto simile a questo, per spirito, tono, uso delle fonti. Ma questo non interessa a nessuno. Dalla quarta di copertina:
Dalla quarta di copertina: Baby Dick.
Baby Dick. 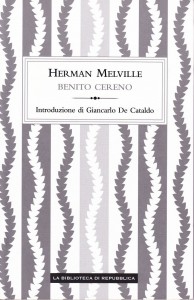
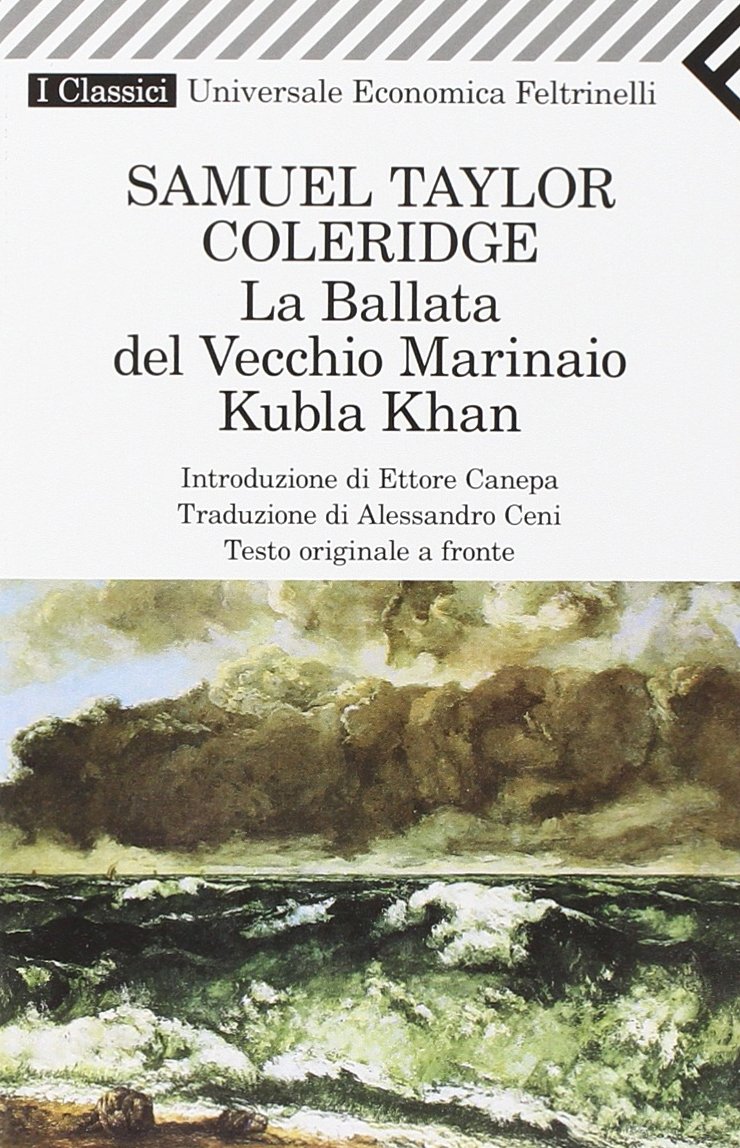 Nell’era di Project Gutenberg la ragione per cui ho preso in prestito quest’edizione è duplice: il piacere di rileggere l’originale e la curiosità di consultare la traduzione.
Nell’era di Project Gutenberg la ragione per cui ho preso in prestito quest’edizione è duplice: il piacere di rileggere l’originale e la curiosità di consultare la traduzione.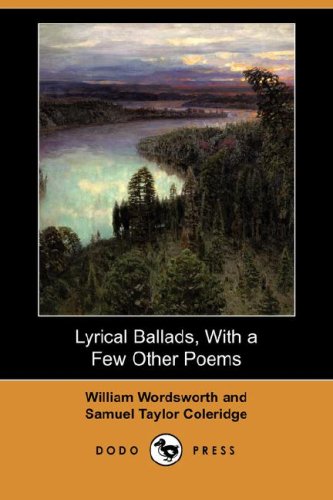 The publishing of Lyrical Ballads, with a Few Other Poems in 1798 is usually regarded as the birth certificate of the Romantic movement in English litterae.
The publishing of Lyrical Ballads, with a Few Other Poems in 1798 is usually regarded as the birth certificate of the Romantic movement in English litterae.
Ho scoperto l’esistenza dei romanzi in tre righe, e del loro autore, grazie ad una menzione di Matteo Codignola nel suo Un tentativo di balena. Quel libro parla dello spettacolo teatrale di 15 minuti che Roberto Abbiati ha tratto da Moby Dick (a sua volta una miniaturizzazione non da poco) e Codignola ne approfitta per fare una carellata delle narrazioni più brevi mai pubblicate. Ne parlo per esteso perché c’è più di un punto di contatto con il libriccino in questione. Non da ultimo il fatto che è curato dallo stesso Codignola. Che si conferma un narratore sempre acuto ed interessante. Come dicevo a proposito di Un tentativo di balena, se finissi per lavorare nell’editoria (e SE fossi bravo quanto lui) la mia prosa sarebbe probabilmente simile alla sua. Un estratto dalla sua postfazione:
Le “brevissime” non erano un’invenzione del Matin ― al contrario, apparivano su ogni quotidiano di quegli anni, indipendentemente dall’autorevolezza del medesimo. In un giornalismo in cui la distinzione tra fatti e fattoidi non era considerata dirimente, e il concetto di riscontro suonava come un’utopia futurista, si riteneva che quotidiani e periodici dovessero offrire ai lettori, insieme alle notizie, anche una robuta dose d’invenzione ― e che i lettori chiedessero d’essere informati, ma contestualmente anche intrattenuti, e stupiti. Non era un’idea della comunicazione poi molto diversa da quella che abbiamo sotto gli occhi, però questo è un altro discorso.
Qui Codignola si occupa di selezionare alcune tra le circa 1500 narrazioni che Fénéon redasse per la sua rubrica, anonima, sul quotidiano Matin, nella maggior parte dei casi nel 1906.
Félix Fénéon era un personaggio assolutamente sui generis tra gli artisti, peraltro certo non conformisti, della Parigi fin de siècle. Impiegato ‘impeccabile’ del Ministero della Guerra, critico d’arte tra i primi a sostenere gli impressionisti, coniatore del termine neo-impressionismo (qui il ritratto che gli fece Paul Signac), collaboratore di un giornale anarchico, poi direttore di un altro giornale anarchico, ed ancora direttore della Revue Blanche (dove il suo critico letterario era Gide e quello musicale Debussy, come ricorda Codignola) ed editore in proprio con le Éditions de la Sirène. Tanto preciso e millimetrico nella prosa quanto evasivo e sfuggente nella vita. Spesso firmava i suoi pezzi con uno pseudonimo; in altri casi non li firmava affatto.
Sulla terza dimensione
A volte la rete falsifica la percezione sulle dimensioni reali dei libri. Quelli della collana “Biblioteca minima Adelphi” sono molto piccoli, 16.5 x 10 cm, e contano in genere una cinquantina di pagine. In pratica non si tratta di un libro, ma di un segnalibro. Il segnalibro più intelligente, geniale e divertente che io abbia mai avuto per le mani.
Sulla quarta dimensione
Questi romanzi in tre righe entreranno discretamente a far parte delle vostre letture quotidiane per non uscirne più. Io li rileggo di continuo. Grazie a Fénéon è sempre il 1906. Oltretutto il libro è talmente piccolo da poter essere infilato in un altro libro.
Sul prezzo
50 pagine, di queste dimensioni oltretutto, a più di €1 sono un furto.
Io l’ho comprato al 20% di sconto, e solo perché il libro è una convergenza strabiliante di ossessioni più o meno recenti: Codignola, le narrazioni miniaturizzate, l’epoca vittoriana, la riflessione metanarrativa, il giornalismo ottocentesco, e ovviamente l’anarchismo. Ma voi pensateci prima di spendere.
p.s. Fénéon è finito anche su Fifty-Two Stories.
Félix Fénéon
Romanzi in tre righe
pp. 58, €5,5
a cura di Matteo Codignola
Adelphi, 2009
Giudizio: 5/5.