 “E questo è il famoso sonno della giovinezza quando si fanno tanti sogni, e poi qualcuno riesce a svegliarsi e altri no”.
“E questo è il famoso sonno della giovinezza quando si fanno tanti sogni, e poi qualcuno riesce a svegliarsi e altri no”.
Seconda parte della trilogia composta da Le avventure di Guizzardi (1972), La banda dei sospiri (1976) e Lunario del paradiso (1978), riunita nel 1989 sotto il titolo di Parlamenti buffi.
Uno dei libri più divertenti mai letti.
È un romanzo di formazione, anche se me ne sono accorto dopo un pezzo. È anche uno dei più belli, e pure questo io l’ho capito tardi. Perché Celati è un maestro della dissimulazione.
Il libro è il racconto in prima persona di un bambino (soprannominato Garibaldi “perché corre sempre”) della propria infanzia e giovinezza, e delle persone che la popolano. La galleria dei personaggi è impagabile; nessuno ha un nome proprio, solo soprannomi. L’indolente fratello maggiore di Garibaldi addirittura li cambia a seconda delle sue letture più recenti: prima Strogoff, poi Nemo e infine Fogg. Il padre, guardia notturna perennemente inviperito con i superiori, viene chiamato Barbarossa per il carattere irascibile. Molti soprannomi poi sono cinematografici: l’aiutante della madre sarta è chiamata Veronica Lake (con prevedibili conseguenze sui maschi della famiglia, quando lei si trasferirà in casa…), il fratello di lei Alan Ladd.
Spesso Garibaldi, a causa della giovane età, non capisce appieno le situazioni in cui si trova coinvolto, generando equivoci che per le risate faranno rovesciare dalla sedia i lettori: ad esempio nei suoi primi approcci sessuali…
Ma, come dicevo, Celati è un maestro della dissimulazione.
La voce narrativa di Garibaldi è colloquiale, bassa, sgrammaticata: uno slapstick assolutamente esilarante. Eppure dissimula un vocabolario ricco per quanto strampalato. L’immediatezza della narrazione cela una ricerca ed uno studio accurati; tra le righe del racconto di Garibaldi bambino va spesso ricostruito il non detto. Come nel caso dello zio d’Australia, fratello di Barbarossa e “un bel po’ ammalato di politica, che in Australia non si trovava bene perché il governo voleva assassinarlo” la cui bella moglie è vedova di un altro emigrante “morto laggiù di crepacuore assassinato dal governo”. E questo è solamente un esempio di quanto sia smaliziato Celati, e di quale sia la sua maestria nel filtrare il tutto attraverso lo sguardo di Garibaldi.
Il titolo stesso cela più di un significato.
La banda dei sospiri non è solo la sgangherata famiglia perennemente afflitta di Garibaldi, ma anche il nastro magnetico su cui il racconto del narratore, ovviamente orale, viene registrato. Allo stesso modo i Parlamenti buffi non sono curiosi assembramenti politici quanto racconti, chiacchiere, parole nel registro basso. Non a caso, nella copertina dell’edizione Feltrinelli Impronte 1989 c’è un quadro di Pieter Bruegel, Giochi di fanciulli del 1560.
Non sono sicuro che quell’edizione sia ancora reperibile, ma il libro è nel catalogo Feltrinelli—sebbene fosse stato pubblicato in origine da Einaudi, probabilmente per intercessione di Calvino, a cui Celati era legato da ammirazione e stima reciproca. I parlamenti buffi sono infatti dedicati alla memoria di Calvino.
Ho letto il libro per un corso universitario: Enrico Palandri, il professore, era un ex-allievo di Celati, e questo ha creato un curioso corto circuito docente/studente. Mentre preparavo l’esame nella biblioteca umanistica dell’università, nella sala al primo piano (molto più tranquilla di quella al pian terreno, dove per forza di cose c’è sempre un certo via vai di gente che entra ed esce), non riuscivo a smettere di ridere ogni due paragrafi.
Il libro ho dovuto portarmelo a casa.
Mica potevo continuare a ridere a quel modo.
Non in pubblico!
Gianni Celati
La banda dei sospiri: Romanzo d’infanzia, in Parlamenti buffi
pp. 400, €16,53
Feltrinelli, 1989
Giudizio: 4/5.
 Enrico Palandri è docente alla Ca’ Foscari di Venezia e alla UCL di Londra (pendolarismo radicale) e questa raccolta di saggi tra critica letteraria, considerazione personale e autobiografia era parte del programma d’esame del suo corso. Io l’ho vissuto soprattutto come un’estensione delle sue lezioni, sempre attente al dialogo con gli allievi (e in quest’ottica mi è dispiaciuto molto che la mia annata, a causa delle varie facoltà di provenienza degli studenti, fosse in un certo senso fin troppo eterogenea e giungesse raramente a un punto d’incontro). E d’altro canto le riflessioni di Palandri partivano spesso da questi suoi scritti, o da altri che si premurava di spedirci via email; ricordo ancora quello sullo “spatrio”, un tema senz’altro cruciale per scrittori transfughi come lui e Celati.
Enrico Palandri è docente alla Ca’ Foscari di Venezia e alla UCL di Londra (pendolarismo radicale) e questa raccolta di saggi tra critica letteraria, considerazione personale e autobiografia era parte del programma d’esame del suo corso. Io l’ho vissuto soprattutto come un’estensione delle sue lezioni, sempre attente al dialogo con gli allievi (e in quest’ottica mi è dispiaciuto molto che la mia annata, a causa delle varie facoltà di provenienza degli studenti, fosse in un certo senso fin troppo eterogenea e giungesse raramente a un punto d’incontro). E d’altro canto le riflessioni di Palandri partivano spesso da questi suoi scritti, o da altri che si premurava di spedirci via email; ricordo ancora quello sullo “spatrio”, un tema senz’altro cruciale per scrittori transfughi come lui e Celati. Sono venuto per le balene e sono rimasto per il paesaggio.
Sono venuto per le balene e sono rimasto per il paesaggio. Il testo è organizzato così: ad un’introduzione generale che illustra motivi, metodi e direttive dei viaggi durante il medioevo arabo, seguono dieci schede monografiche sulla biografia ed i viaggi dei più significativi viaggiatori arabi, ciascuna corredata da un brano scelto tra i resoconti dei suddetti.
Il testo è organizzato così: ad un’introduzione generale che illustra motivi, metodi e direttive dei viaggi durante il medioevo arabo, seguono dieci schede monografiche sulla biografia ed i viaggi dei più significativi viaggiatori arabi, ciascuna corredata da un brano scelto tra i resoconti dei suddetti. Ho conosciuto Ornela Vorpsi ad
Ho conosciuto Ornela Vorpsi ad 
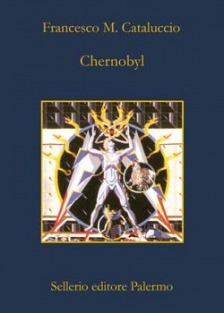 Artemisia, o della dimenticanza.
Artemisia, o della dimenticanza. 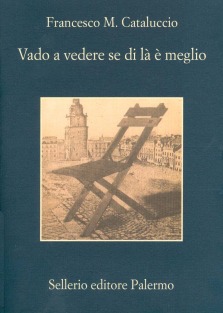 Polacchi di tutto il mondo, disperdetevi.
Polacchi di tutto il mondo, disperdetevi.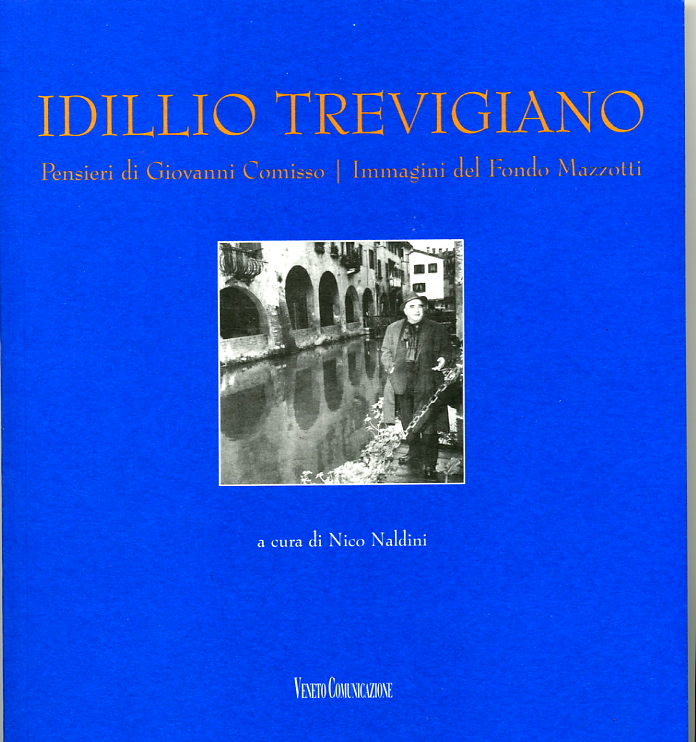
Ristampato trent’anni dopo (c’è una riproduzione della copertina originale delle Ed. Quadrifoglio), il libro è un documento molto interessante di cosa si studiava in quei mesi concitati, ma anche di come. Il testo è letteralmente costellato di note a margine che riportano i commenti a latere di studenti e studentesse alle lezioni: un florilegio di punti di vista discordanti, deviazioni, contronarrazioni. Aver mantenuto l’impianto plurale e collettivo del discorso è a mio parere uno dei meriti di Celati, anche se paradossalmente il risultato dovesse risentirne. In verità il testo è un po’ sui generis: a tratti è ripetitivo, mentre alcuni punti sono concettualmente molto densi.
Molto belle le foto (la copertina non è tra le migliori). Alcune sono drammatiche, come i carri armati in città o la famosa ragazza con carabinieri; altre invece sono impagabili, come gli slogan che sembravano tappezzare ogni superficie:
“L’anima è la galera del corpo”
“Dichiaro lo stato di felicità permenente”
“GIÙ LE MANI DA RADIO ALICEEEEEEEE!”
Paradossalmente, se dovessi farmi firmare un libro da Celati, sceglierei questo.
Sull’epoca di questo libro
L’allegria che ha cercato di farsi strada nel nostro libro deve sempre rinunciare all’idea di sapere come stato di coscienza, il sapere stagno da professionista patentato. E deve accettare questo modo slegato, pagliaccesco, con alti e bassi secondo i momenti. Perché la positività è sempre questione di momenti; è l’atmosfera, l’intonazione del momento esaltante o angoscioso, in cui si annuncia un’apertura mentale. L’adesione al movimento trascende ogni tipo di sapere, ogni forma d’interiorità, perché ci rimanda ad un avvenire al di là di noi; e mentre sospendo le ansie competitive, aiuta a pensare a una comunità possibile, senza “messaggi”.
— Gianni Celati, novembre 2006
Gianni Celati
Alice disambientata: Materiali collettivi (su Alice) per un manuale di sopravvivenza
postfazione di Andrea Cortellessa
pp. 160, €15
Le Lettere, 2007
Giudizio: 3/5.